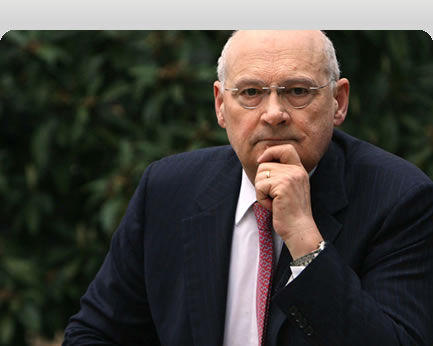
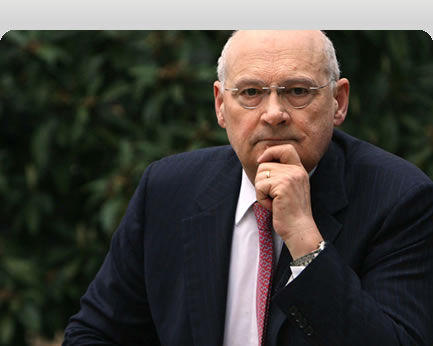
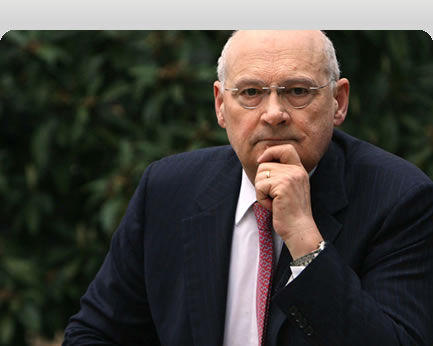
La famiglia, speranza e futuro per la società italiana
Torino, 12-15 settembre 2013
1. Introduzione e motivazione
Un paradosso, tra i tanti, connota di sé la nostra società. Mentre è ormai ampiamente diffusa la consapevolezza del ruolo decisivo che la famiglia svolge come soggetto sociale e come produttore di importanti esternalità positive che vanno a beneficio dell'intera società, non procede con uguale consapevolezza la messa in cantiere di provvedimenti e di misure volti ad una politica della famiglia in sostituzione delle inadeguate politiche per la famiglia. Non procedono cioè allo stesso ritmo il riconoscimento da un lato e la valorizzazione dall'altro che la politica “deve” alla famiglia per la mole di beni di varia natura (non di merci) che nessuno Stato, nessun mercato, nessuna agenzia pubblica possono surrogare in modo equivalente. È vero che tale divario riguarda un po' tutta l'Europa, ma in Italia esso assume un'ampiezza particolarmente preoccupante.
Assai opportunamente, la 47a settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Torino, 12-15 settembre) ha dunque scelto come tema: “La famiglia, speranza e futuro per la società italiana”. Il titolo, assai azzeccato, dice dell'attenzione e del coinvolgimento del mondo cattolico italiano nell'affrontare quella che, con buone ragioni, si può oramai chiamare l'emergenza familiare. È un fatto che, nonostante una certa retorica di maniera, nel nostro paese si continua a vedere la famiglia solamente come una delle voci di spesa del bilancio pubblico e non anche come risorsa strategica per lo sviluppo umano integrale. Del pari, si continua a considerare la famiglia variabile dipendente che, in quanto tale, deve adeguarsi a quanto viene deciso per gli altri attori sociali. E soprattutto non riesce ad essere accettata l'idea che la famiglia, prima ancora di essere soggetto di consumo, è soggetto di produzione. Oggi, v'è un'abbondante evidenza empirica che indica come la famiglia sia il massimo generatore di capitale umano, capitale sociale, capitale relazionale; altro che luogo di affetti e basta! Come la Seconda Conferenza Nazionale delle Famiglie del novembre 2010 a Milano ha chiaramente posto in luce, non solamente la spesa pubblica italiana per i servizi alla famiglia sia immeritatamente bassa (contro una media UE dell'8% della spesa sociale, l'Italia destina alla famiglia il 4,1%). Ma, le modalità con cui vengono combinate le politiche che attribuiscono alla famiglia risorse di tempo (orari flessibili, part-time, congedi parentali, etc.), risorse monetarie (deduzioni e/o detrazioni; buoni per l'acquisto di beni e servizi, tariffe, etc.), risorse per la fornitura diretta di servizi di cura sono tali da determinare spesso effetti perversi.
Questo accade perché si continua ad avanzare con politiche settoriali per età (bambini, giovani, anziani non autosufficienti, etc.), anziché passare a politiche del corso di vita aventi per fine un sistema integrato per la promozione del benessere familiare. La famiglia, infatti, non è una somma di segmenti tra loro indipendenti, ma un prodotto degli stessi: se uno di questi soffre, è l'intera famiglia a risentirne! Ce lo ricorda l'efficace Documento Preparatorio del Comitato Scientifico e Organizzatore quando, citando Giovanni Paolo II, scrive: “È necessario soprattutto passare da una considerazione delle famiglie come settore ad una visione della famiglia come criterio di misura di tutta l'azione politica, perché al bene delle famiglie sono correlate tutte le dimensioni della vita umana e sociale.” (Messaggio al Presidente della CEI a Vent'anni dalla “Familiaris Consortio”, 15 ottobre 2001).
È noto che uno dei temi oggi di maggior rilevanza è quello della complessa relazione tra vita familiare e vita lavorativa. Nella letteratura in argomento e nel dibattito pubblico contemporaneo questo tema viene reso con l'espressione work-life balance, cioè a dire bilanciamento, conciliazione tra famiglia e lavoro. Si tratta di un'espressione infelice che tradisce una certa impostazione culturale che il mondo cattolico non riesce a condividere. Il termine stesso di conciliazione, infatti, postula l'esistenza di un conflitto, o meglio di un trade-off quanto meno potenziale, tra questi due fondamentali ambiti di vita, ciascuno dei quali dotato di una sua propria specificità e di un suo proprio senso. Ritengo invece che non vi siano ragioni di principio che possano far parlare di due polarità tra cui è necessario stabilire pratiche conciliative, perché se è vero che quello del lavoro è anche un tempo di vita, del pari vero è che la vita familiare include una specifica attività lavorativa, anche se questa non transita per il mercato. In un pregevole e assai utile contributo del Comitato per il progetto culturale della CEI si legge che il valore annuale complessivo del lavoro familiare, secondo il metodo del costo opportunità, si aggirerebbe sui 570 miliardi di euro e quello ottenuto secondo il metodo di calcolo del costo del servizio sarebbe all'incirca di 433 miliardi di euro. Dunque, il lavoro domestico ha un peso economico ragguardevole in Italia: circa un quarto del PIL nazionale. (Cfr. CEI, Per il lavoro, Laterza, Roma, 2013, cap. 3). Si tratta dunque, per un verso, di andare oltre una concezione puramente materialistica e strumentalista del lavoro, secondo cui quest'ultimo sarebbe solo pena e alienazione e, per l'altro verso, di smetterla di concepire la famiglia come luogo di solo consumo e non anche come un soggetto produttivo per eccellenza, generatore soprattutto di quei beni immateriali (fiducia, reciprocità, beni relazionali, dono come gratuità) senza i quali una società non sarebbe capace di futuro. È il dualismo (si badi, non la dualità) famiglia lavoro ad aver veicolato l'idea che le politiche di conciliazione, di cui tanto si va parlando anche nel nostro paese da ormai diversi anni, dovrebbero limitare a mirare, da un lato, a migliorare la produttività delle imprese e, dall'altro, ad accelerare il processo verso la piena liberazione della donna dalla segregazione occupazionale. (Cfr. S. e V. Zamagni, Famiglia e lavoro. Conflitto o armonia?, Milano, San Paolo, 2012).
Ecco perché al termine conciliazione preferisco quello di armonizzazione responsabile. Nel greco antico, armonia era l'intercapedine che occorreva frapporre tra due corpi metallici perché, sfregandosi, non andassero a produrre attrito e quindi scintille pericolose. L'idea di armonia è dunque quella di concordia discors. Duplice, allora, il fine che è bene attribuire alle politiche di armonizzazione tra famiglia e lavoro (di mercato): superare la diffusa femminilizzazione della questione conciliativa a favore di un approccio reciprocitario tra famiglia e lavoro, per un verso; provocare un ripensamento radicale circa il modo in cui avviene l'organizzazione del lavoro nell'impresa di oggi, per l'altro verso.
Duplice l'intento che assegno a questo saggio, i cui contenuti fanno esplicito riferimento alla Parte III (“Famiglia, società e economia”) del Documento preparatorio. Per un verso, mi propongo di portare ragioni a sostegno della famiglia che è la struttura antropologica che, oggi, più di ogni altra, è nell'occhio del ciclone che ha investito l'occidente secolarizzato. Per l'altro verso, mi occuperò di avanzare suggerimenti di policy che possano essere traducibili in progetti di facile approntamento e soprattutto compatibili con il vincolo del nostro bilancio pubblico.
2. Presupposti per una diversa politica della famiglia
Quali i presupposti indispensabili per dare corso ad una politica della famiglia che veda questa come prima responsabile del benessere materiale e spirituale dei suoi membri, e come primo generatore di socievolezza, e non semplicemente di socialità? (La socialità è la propensione naturale a vivere in società. Anche talune specie animali esibiscono tale qualità. La socievolezza, invece, è il desiderio, che alimenta il bisogno, di essere in relazione con l'altro – un'idea questa che risale ad Aristotele quando ammoniva che per essere felici occorre essere almeno in due). Mi soffermo ad indicarne tre.
Il primo presupposto chiama in causa la dimensione economico-culturale. Si tratta di affermare il principio secondo cui la famiglia va vista come soggetto dotato di una sua propria identità e autonomia e non già come un mero aggregatore di preferenze individuali. L'accoglimento di un tale principio deve avere come primo effetto quello di favorire una riconcettualizzazione del modo usuale di concepire il funzionamento di un'economia di mercato. Mi spiego. Nei nostri sistemi di contabilità nazionale due sono gli operatori della sfera privata ivi contemplati: le imprese e le famiglie. Le prime sono deputate allo svolgimento dell'attività produttiva: le imprese non consumano, ma utilizzano – così si dice – i fattori produttivi per conseguire i loro scopi. Alle famiglie spetta invece l'attività di consumo, vale a dire l'acquisto di beni e servizi prodotti dalle imprese. Le famiglie non producono alcunché secondo la contabilità nazionale. È dunque chiara la divisione dei ruoli: la famiglia, in quanto luogo in cui si soddisfano i bisogni, è il soggetto cui si attribuisce la funzione del consumo; l'impresa, in quanto soggetto responsabile del processo di sviluppo, è il luogo in cui si realizza la funzione di produzione.
Una volta postulato che all'interno della famiglia non v'è produzione di sorta, si arriva a comprendere perché nel calcolo del reddito nazionale non vi sia posto per tutto ciò che di produttivo la famiglia realizza. Così, per fare un esempio: il pasto preparato in famiglia non viene contabilizzato come attività di produzione, ma come attività di consumo misurata dall'acquisto sul mercato dei beni che servono alla preparazione del pasto stesso. Eppure, il medesimo pasto consumato in un ristorante viene contabilizzato come attività di produzione. Ancora: la cura di un minore svolta da un genitore entro le mura domestiche è contabilizzata come attività di consumo; la medesima cura fornita da una “colf” entra invece nel calcolo del reddito nazionale, come espressione di attività produttiva. E così via.
Il secondo presupposto di una nuova politica della famiglia concerne la soggettività economica della stessa. Come suggerisce il titolo di una recente pubblicazione dell'Unione Giuristi Cattolici di Roma, la famiglia è la prima impresa, in quanto produttore di esternalità sociali positive per l'intera società. Se le cose stanno – come stanno – in questi termini il sostegno economico deve allora assumere il carattere della restituzione ovvero della compensazione e non già – come continua ad essere – della compassione o dell'assistenzialismo paternalistico.
Quali linee di azione scaturirebbero dall'accoglimento del principio di compensazione? La prima e più importante è quella fiscale. È vera l'obiezione di chi, pur dichiarandosi d'accordo col principio dell'equità orizzontale a favore delle famiglie con figli, non lo ritiene applicabile per motivi tecnici? Oppure è vero che il disinteresse per l'equità orizzontale è conseguenza di una posizione culturale di marcato individualismo, secondo cui la decisione di generare figli appartiene alla sola sfera privata privata dei genitori, una sfera rispetto alla quale lo Stato non deve interferire? Sono dell'avviso che la recente proposta del “fattore famiglia” avanza dal Forum delle Associazioni Familiari vada nella direzione giusta, e quindi vada sostenuta, anche perché essa è in grado di annullare le obiezioni contro l'adozione del quoziente familiare sollevate da parte di chi teme che quest'ultimo possa avere effetti regressivi.
Una seconda linea di intervento riguarda tutte quelle misure che tendono a ridurre l'incertezza endogena oggi gravante sulle famiglie, soprattutto su quelle giovani. Da sempre, la creazione di una nuova ricchezza e il conseguente miglioramento delle condizioni di vita sono serviti a ridurre l'incertezza di vita dei singoli e delle famiglie. L'avvento della cosiddetta società globale ci pone, invece, di fronte ad una situazione in cui la produzione di incertezza sembra connaturata al problema economico stesso, una sorta di precondizione per l'ulteriore progresso. Il messaggio che veicola la sindrome dell'incertezza – diventata ormai una vera e propria sociopatia, soprattutto tra le giovani generazioni – è quello dell'incertezza naturale ovvero “fabbricata”, come la chiama A. Giddens: le persone sono indotte a pensare che occorra autoinfliggersi una certa dose di incertezza per migliorare le performance economiche. Non ci si deve allora meravigliare se, all'interno di un simile contesto culturale, le giovani famiglie si formano in età avanzata e soprattutto se l'attività procreativa si limita ad un solo figlio. Come venirne fuori? Si tratta di pensare ad iniziative volte ad assicurare una qualche forma di reddito permanente alla famiglia, in sostituzione dell'ormai obsoleto concetto di sussidi integrativi del reddito familiare. Nelle condizioni odierne, infatti, alla famiglia interessa assai più la prospettiva di una sorta di reddito permanente, che non trasferimenti monetari temporanei.
Di un terzo presupposto essenziale per giungere ad impostare una credibile politica delle famiglie desidero dire. Si tratta di pensare alla famiglia come una speciale azione comune. Come suggerisce Francesco Viola (Le forme della cooperazione, Bologna, Il Mulino, 2006), tre sono gli elementi identificativi dell'azione comune. Il primo è che essa non può essere condotta a termine senza che tutti coloro che vi prendono parte siano consapevoli di ciò che fanno. Il mero convenire o ritrovarsi di più soggetti non basta alla bisogna. Il secondo elemento è che ciascun partecipante all'azione comune conserva la titolarità e dunque la responsabilità di ciò che compie. È questo elemento a differenziare quella comune dall'azione collettiva. In quest'ultima, infatti, l'individuo con la sua identità scompare e così scompare la responsabilità personale di quel che fa. Il terzo elemento, infine, è l'unificazione degli sforzi da parte dei partecipanti all'azione comune per il conseguimento di un medesimo obiettivo. L'interazione di più soggetti all'interno di un dato contesto non è ancora azione comune, se costoro perseguono obiettivi divergenti. La famiglia, in quanto possiede tutti e tre questi elementi, è propriamente un'azione comune.
Tuttavia, diversi sono i tipi di azione comune – e quindi diversi i tipi di famiglia – che si danno nella pratica, e ciò in relazione a quel che costituisce l'oggetto della comunanza. Questo, infatti, può riguardare i soli mezzi oppure può estendersi ai fini dell'azione stessa. Nel primo caso, la famiglia si riduce a poco più che ad una sorta di società di mutuo soccorso e la forma che l'intersoggettività in essa assume è, tipicamente, quella del contratto. Come sappiamo, nel contratto le parti devono bensì concorrere alla sua completa realizzazione, ma ciascuna persegue fini diversi, spesso divergenti. (Si pensi, per un esempio generale, a quanto avviene nel contratto di lavoro). Invece, quando la comunanza viene estesa anche ai fini, si ha la famiglia come bene umano comune. Si osservi che c'è differenza tra la situazione in cui in un insieme di persone si accetta che ognuno persegua il proprio fine e la situazione in cui si ha un fine comune da condividere. Nel primo caso si ha l'unione (“unio”) familiare; nel secondo caso l'unità (“unitas”) familiare.
Quale la conseguenza, al fine del disegno delle politiche familiari, che discende dalla distinzione tracciata? Che quando il “comune” dell'azione si ferma ai soli mezzi, il problema da risolvere è sostanzialmente quello della coordinazione degli atti di un certo numero di soggetti. A ciò provvedono le tradizionali politiche di conciliazione fra famiglia e lavoro. D'altro canto, quando il “comune” dell'azione si estende anche ai fini, il problema assai più delicato che va risolto è come realizzare la cooperazione; il che costituisce il proprium delle politiche di armonizzazione. Per dirla in altri termini, un problema di coordinazione nasce dall'interdipendenza strategica di più soggetti; un problema di cooperazione, invece, nasce dalla loro interdipendenza assiologica. Come dire che nella cooperazione l'intersoggettività è un valore perché “nell'esser-con” è inscritta una bontà propria; nella coordinazione invece essa è una circostanza, a volte perfino fastidiosa. (Si pensi alle miriadi di situazioni che contraddistinguono non poche unioni familiari).
Come fare per risolvere positivamente un problema di cooperazione e dunque per vivere l'esperienza del bene umano comune che dimora nell'unità familiare? Tre sono le condizioni che si possono indicare. In primo luogo, ciascun partecipante all'azione comune – cioè ciascun membro della famiglia – assume come rilevante e meritevole di rispetto le intenzioni degli altri, sapendo che questi faranno altrettanto. In secondo luogo, ciascuno si impegna in una attività congiunta e sa che anche gli altri intendono fare lo stesso. È questo il committment to the joint activity secondo cui ognuno si impegna al pieno delle sue capacità, pur sapendo che è impossibile determinare esattamente il contributo che ciascuno darà al risultato finale. Infine, c'è il committment to mutual support: ognuno si impegna ad aiutare gli altri durante lo svolgimento dell'attività in questione, non al termine della stessa, come accade con il paternalismo più o meno disinteressato.
Sorge spontanea la domanda: come è possibile che la società contemporanea sempre più tesa a “individualizzare gli individui” - come si esprime Baumann – riesca a conservare l'identità della famiglia, scongiurando il rischio dell'alterazione del suo genoma? In un contesto quale quello odierno, profondamente segnato da fenomeni quali la globalizzazione e la terza rivoluzione industriale, si può pensare (e sperare) che, mediante l'approntamento di adeguate politiche famigliari, si riesca a rafforzare la fruizione del bene umano comune della famiglia? La posizione che difendo è che solamente una famiglia forte al proprio interno – cioè capace di soddisfare in modo armonico le condizioni di cui sopra si è detto – è in grado di esercitare un forte potere di contrattazione nei confronti sia dell'impresa sia dello Stato. È forse per tale ragione che una certa cultura favorisce la tendenziale scissione tra uomo e donna in nome del mito dalla singleness. L'obiettivo è chiaro: indebolire la famiglia significa, infatti, dominarla e asservirla a interessi di parte. Come vuole il funzionalismo, la famiglia viene pensata come una sfera delegata dalla società a svolgere certe funzioni, tutte importanti e di grande interesse pratico. A tal fine, viene approntata tutta una serie di politiche – si pensi alle politiche contro la povertà e contro l'esclusione sociale; alle politiche per l'infanzia, per la natalità, per gli anziani non autosufficienti; alle politiche di gender – le quali, pur di per sé dotate di senso, ben poco contribuiscono a rafforzare e rigenerare il suo genoma.
3. Proposte economicamente possibili e agevolmente trasformabili in progetti operativi
3.1. Che fare, allora? La risposta più concreta e più efficace che mi sento di suggerire è: dare attuazione, in modo progressivo ma sistematico, al Piano Nazionale per la Famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012. Si badi che questo è stato il primo piano che l'Italia si è finora data per le politiche familiari. (Se si prescinde dalla peraltro controversa revisione dell'ISEE approvata nel giugno 2013 – il cosiddetto “riccometro” impiegato per selezionare l'accesso ai servizi da parte di portatori di bisogni – e dell'aumento delle detrazioni per figli a carico, da 800 a 950 euro annui per figlio, reinserito nell'ultima legge di stabilità, null'altro di quanto scritto nel Piano è stato finora realizzato).
Raggrupperò le proposte per dare attuazione al Piano in tre classi di provvedimenti; selezionati secondo il duplice criterio della sostenibilità finanziaria pubblica e dell'urgenza. Preferisco di gran lunga un approccio per così dire di tipo pragmatico basato sul gradualismo ai tanti tentativi esperiti nel passato recente per arrivare alla “grande riforma” dell'istituto familiare. Si è poi visto l'esito di questa forma di massimalismo. Nell'Unione Europea, nell'ultimo quindicennio, tutti i paesi, eccetto due, si sono adoperati a favore della famiglia: il reddito minimo in Spagna; il piano nidi in Germania; misure base contro le povertà in Portogallo; fondo per la non autosufficienza in Francia; ecc. Gli unici due paesi che non hanno varato neppure una riforma nazionale lungo i tre assi della povertà, non autosufficienza, prima infanzia, sono il nostro e la Grecia! Le tre classi di provvedimenti cui farò riferimento concernono: a) il fisco e la revisione delle tariffe; b) gli interventi di armonizzazione tra famiglia e lavoro; c) l'innovazione dell'assetto istituzionale per renderlo capace di accogliere il principio di sussidiarietà circolare. Tuttavia, prima di entrare nello specifico, desiderio premettere un'osservazione di carattere generale.
Osserva correttamente Giuseppe Dalla Torre (2013) che il legislatore italiano del 1975, riformando il diritto di famiglia, ha liberato la stessa dalle funzioni sociali, educative, assistenziali e produttive, che storicamente l'avevano sempre connotata. È accaduto così che la famiglia sia stata ridotta a mero luogo degli affetti. Un'operazione di riduzionismo questa che – passata inosservata all'inizio – sta avendo conseguenze devastanti per il futuro della famiglia. Infatti, se con quell'espressione si intende significare che la famiglia esiste ed ha ragione di esistere nella misura in cui perdurano rapporti effettivi, allora si deve concludere che ogniqualvolta quei rapporti vengono ad interrompersi la famiglia non ha più senso. Non ci voleva molto a comprendere quali implicazioni pratiche sarebbero derivate da tale insostenibile posizione. (Ma, forse, l'attenzione del legislatore dell'epoca era indirizzata altrove!). Perché, come scrive Francesco D'Agostino (Avvenire, 11 aprile 2013) il matrimonio, su cui è fondata la famiglia, non esiste per garantire la sensibilità dei coniugi, ma per consentire la costruzione di comunità familiari, alle quali la società, per mezzo dello Stato, affida i progetti intergenerazionali di convivenza. Tanto è vero che si agevola economicamente e giuridicamente la famiglia perché si riconosce (art. 31 Costituzione) che essa è un'organizzazione con fini produttivi e non meramente affettivi. Questi ultimi sono bensì rilevanti e presenti nella famiglia, ma l'affetto non è certo una categoria giuridicamente rilevabile.
Ecco perché occorre recuperare, e in fretta, la concezione della famiglia come “prima impresa”, come punto di riferimento socio-economico fondamentale per l'intera società. Non si può continuare a tenere in vita, nel nostro ordinamento giuridico, il dualismo tra il modello famigliare e il modello imprenditoriale – un dualismo che non può certo farsi risalire alla Costituzione, la quale si muove in tutt'altra direzione. All'origine di tale frattura ha contribuito anche la posizione – difesa certamente in buona fede – di una componente della nostra tradizione cattolica che ha sempre dato pressoché esclusivo rilievo alla dimensione della spiritualità della famiglia. Ma ciò non basta, perché la famiglia è un bene umano fondamentale, prima ancora di essere un bene cristiano, ed in quanto tale, la sua dimensione sociale ed economica non può essere lasciata ai margini del discorso politico. La nozione di bene comune familiare non è compatibile con una certa visione intimistica e in fin dei conti ideologica della famiglia che la considera alla stregua di una tra le tante modalità di vita degli individui. Discende di qui quella metodologia giuridica che parcellizza i diversi aspetti della realtà familiare, con il che la famiglia viene, di volta in volta, considerata luogo degli affetti, ente che garantisce la trasmissione della proprietà, soggetto erogatore di servizi di welfare e così via. Una “legge quadro” sulla famiglia, da tempo attesa e da più parti invocata, dovrebbe ricomporre quanto è stato artificialmente diviso con la riforma del 1975. (Dopo tutto, sono già passati quasi quarant'anni!).
3.2. Gli interventi aventi per oggetto il trattamento fiscale dei redditi familiari devono partire dalla considerazione che la L. 179/1976 abrogò il cumulo dei redditi che era stato previsto dalla riforma Visentini. La successiva legge 76/1983 ribadì l'obbligo della tassazione separata ddi redditi dei coniugi. Facendolo discendere dall'art. 53 della Costituzione, la Corte Costituzionale, nel sancire il principio secondo cui l'imposizione fiscale non può che essere personale, espresse tuttavia l'auspicio che ai coniugi fosse data la facoltà di scegliere un diverso sistema di tassazione per agevolare “la formazione e lo sviluppo della famiglia”, con un esplicito richiamo all'art. 31. Di lì a poco, la Consulta, investita del caso riguardante il trattamento fiscale delle famiglie monoreddito, ribadì l'imprescindibilità del regime di tassazione separata, ma scrisse che “ spetta allo stesso legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni che da tale sistema potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale solo uno dei coniugi possegga reddito tassabile”. Ma anche in questa occasione il monito non venne raccolto, con le conseguenze a tutti ben note. Per citarne una sola: le unioni civili – che non sono soggette agli stessi obblighi delle coppie sposate – possono essere titolari di due prime case; possono beneficiare della duplicità di agevolazioni per le utenze domestiche; conservano separati i propri redditi a fini fiscali; ecc., mentre tutto questo alle coppie di diritto non è concesso: bel paradosso davvero!
È per questa ragione fondamentale che – come sopra ho ricordato – la proposta avanzata dal Forum delle Associazioni Familiari di accogliere nel nostro ordinamento il “fattore famiglia” - che prevede una no tax area familiare determinata in base al numero dei componenti del nucleo non può non essere accolta con favore. (Va ricordato che la laicissima Francia introdusse il quoziente familiare già nel 1945 e da allora nessuna maggioranza parlamentare ha mai pensato di cancellare tale provvedimento, anche durante l'attuale crisi economica). Certo, occorre prevedere una ragionevole gradualità nella sua applicazione, perché sono a tutti noti i vincoli di finanza pubblica. In tal senso, la defiscalizzazione dei redditi da lavoro, realizzata tenendo conto del numero dei figli, può essere vista come un primo passo verso l'introduzione del fattore famiglia.
Del pari urgente e fattibile è l'eliminazione delle non poche incongruenze – e talvolta contraddizioni – rintracciabili nei diversi capitoli del nostro sistema fiscale. Valgano un paio di esempi. Nella cosiddetta “delega fiscale”, all'art. 1 è prevista la riforma, da tempo attesa, del catasto. Ma non si specifica che, nella rivalutazione delle abitazioni, un appartamento, poniamo, di 90 mq. occupato da una sola persona non è la stessa “casa” di un eguale appartamento abitato da quattro o cinque persone. Oppure, nella revisione della tassa sui rifiuti (TARES), il coefficiente per il terzo figlio è stato portato da 0,40 a 0,70, mentre nella riforma dell'ISEE, il terzo figlio ha visto passare il peso ad esso assegnato da 0,37 a 0,39. È veramente difficile parlare di “equità familiare” di fronte a queste e altre incongruenti decisioni. Si può certo discutere circa l'adozione del metodo migliore per la tariffazione (se a tariffa unica; a scaglioni; lineare; progressiva), ma ciò che non può essere eluso è l'obiettivo di giungere a tariffe eque.
Un aspetto particolare ma di grande rilevanza, che purtroppo viene sistematicamente ignorato nel nostro paese è quello che concerne l'equità intergenerazionale; in pratica, l'allocazione delle risorse tra giovani e anziani. Pieter van Huysse, dell'European Centre for Social Welfare – una organizzazione non governativa affiliata all'ONU – ha elaborato di recente l'indice di giustizia tra generazioni (Intergenerational Justice Index), aggregando quattro indicatori: debito pubblico in capo a ciascun minore; povertà dei minori; spesa sociale per gli anziani rispetto a quella a favore del resto della popolazione; impronta ecologica pro-capite (ettari di superficie bioproduttiva usati, per abitante). Tra i 29 paesi dell'OCSE , quelli con l'indice più alto – da 0,9 a 0,8 – sono Estonia, Sud Corea, Israele, Nuova Zelanda, Ungheria, Paesi Scandinavi. L'Italia, assieme a Grecia, Giappone e USA, esibisce l'indice più basso (circa 0,5). E sappiamo perché. In Italia, la spesa per anziani è sette volte più elevata di quella per il resto della popolazione (nei paesi “più intergenerazionalmente giusti” è solo tre volte maggiore); il debito pubblico per ciascun minorenne è di 5.000 euro in Estonia e di 238.500 euro in Italia! Nel 1977 nel nostro paese, gli ultra 65enni avevano una probabilità doppia della media nazionale di cadere nel 20% della popolazione col reddito più basso. Oggi, gli anziani hanno una minore probabilità della media nazionale; il che significa che in trent'anni sono mutate le fasce di reddito a rischio di povertà. E si potrebbe continuare a lungo in tale direzione.
C'è allora da meravigliarsi quando le cronache ci narrano del disagio crescente delle giovani coppie nei riguardi della genitorialità? È per questo che proposte come quella di riconoscere il diritto di voto dalla nascita, un diritto esercitato dai genitori del minore fino al raggiungimento della maggiore età, non possono essere prese come mera provocazione intellettuale. Si tenga presente, infatti, che in Italia l'età mediana dei residenti è di 44 anni, mentre l'età mediana degli elettori è di 50 anni: quanto a dire che il potere economico e politico è saldamente nelle mani degli anziani, i quali sono assai più interessati – e pour cause – a sostenere le coalizioni distributive che non quelle produttive. Non penso si dovrà attendere ancora a lungo prima che si arrivi a riconoscere alla famiglia la personalità giuridica: passa di qui una familiarmente equa riforma fiscale. D'altro canto, perché imprese formate anche da poche unità personali possono ottenere la personalità giuridica e non altrettanto può esigere la famiglia? La verità è che mentre si continua a concepire la famiglia come ente privato che concerne la libera scelta di due individui, l'impresa è considerata come ente a rilevanza pubblica, al quale si devono perciò riconoscere speciali prerogative.
3.3. Passo ora a quel grande pilastro di una credibile politica promozionale della famiglia che è quello dell'armonizzazione dei tempi di lavoro e tempi di vita familiare e del cui significato ho detto nei paragrafi precedenti. Il punto importante che merita una sottolineatura è che la conciliazione – come questa politica viene ancora chiamata nel dibattito pubblico – viene considerata non un diritto del lavoratore che ha famiglia, ma un'azione in sé virtuosa che però nulla ha a che vedere con l'impianto del Diritto del Lavoro italiano. Le politiche conciliative, in altri termini, sono viste nell'ottica di un problema della famiglia – problema che si deve cercare di limitare il più possibile – piuttosto che di un più avanzato sistema di organizzazione del lavoro per affermare il quale ci vuole il concorso, alla pari, di impresa e famiglia. (È proprio questo elemento ciò che differenzia, in buona sostanza, le politiche di conciliazione da quelle di armonizzazione). Oppure le politiche conciliative vengono declinate nel senso della ricerca delle pari opportunità. È chiaro che, in un'ottica del genere, la gravidanza venga via come ostacolo da superare e, meglio ancora, da eliminare. (Cfr. Forum delle Associazioni Familiari, Le nuove frontiere della conciliazione famiglia-lavoro, Roma 2011).
Si consideri ad esempio, il congedo di maternità. Questa fu una misura introdotta in Italia a livello minimo già nel 1910, ma è solo negli ultimi vent'anni che l'Unione Europea si è mossa con decisione a sostegno di questo istituto e di altri ad esso connessi1. I congedi parentali sono stati introdotti nel nostro paese con la L. 53/2000. La Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza nel 2000 prevedeva (art. 3, comma 2) che “al fine di poter conciliare vita familiare e professionale, ogni individuo [si badi, non solo le donne] ha il diritto di essere tutelato dal licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto ad un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio”. Ma l'applicazione di questo principio resta molto diversa da paese a paese, soprattutto per quel concerne la corresponsione dell'indennità. In Italia, questa è pari al 30% della retribuzione, una percentuale troppo bassa perché il congedo possa diventare una misura efficace. La proposta che qui avanzo è che essa venga portata al 70%, mediante forme di autofinanziamento sulla falsariga di quel che già avviene in parecchi paesi europei. Inoltre, è urgente giungere ad attuare forme di fruizione oraria del congedo parentale, una misura molto apprezzata dalle coppie che hanno più di un figlio, e a riconoscere ai nonni, in alternativa ai genitori, la possibilità di usufruirne. Sarebbe quest'ultima un'innovazione sociale che, mentre costerebbe quasi nulla alle finanze statali, avrebbe un forte significato simbolico: quello della solidarietà intergenerazionale come espressione tipica della catena generazionale. In sostanza, si tratta di mirare ad un modello familiare che sostituisca alla rigida e anacronistica specializzazione dei ruoli di genere, il principio che uomini e donne sono sia genitori sia cittadini lavoratori. È questo il senso del cosiddetto adult worker family model (Cfr. J. Lewis, Work family balance, gender and family, Elgar, 2009).
Che dire del part-time da non confondersi con il lavoro precario? Si tratta di un istituto che concilia lavoro e famiglia soprattutto per le donne, ma viene utilizzato in maniera molto diseguale nei vari paesi: la media europea è cresciuta tra il 1999 e 2009 dal 15,9% al 18,8% del totale degli occupati, ma si articola in modi differenti nei vari paesi. In generale, il part-time è quasi assente nei paesi ex-socialisti e in Grecia; è più elevato nei paesi nordici, in Germania, Austria, Belgio e Gran Bretagna, con l'Olanda che detiene il primato, mentre registra un livello intermedio negli altri paesi. La differenza tra l'utilizzo maschile e femminile è rilevante, ma i livelli di utilizzo maschile sono molto elevati in Olanda (1/4), Svezia e Danimarca (1/6). Infine, viene confermato che il part-time favorisce l'occupabilità, perché alti livelli di part-time sono collegati ad alti livelli di occupazione.
Rendere il part-time più semplice nell'uso e non penalizzante in termini di carriera è dunque un obiettivo molto rilevante ai fini presenti. Occorre però acquisire consapevolezza del fatto che oggi il principale ostacolo alla formazione di nuove famiglie e, all'interno di queste, alla procreazione è la percepita impossibilità da parte di non poche coppie di sciogliere il trade-off tra avanzamenti di carriera e/o di livello professionale nel lavoro e necessità di dedicare ai figli le attenzioni indispensabili per la loro educazione. Se le cose stanno in questi termini, la questione urgente da affrontare è quella di studiare tipi specifici di politiche d'uso del tempo, tenendo presente che il problema non è solo quello della riduzione delle ore di lavoro settimanali o mensili, quanto piuttosto quello, assai più complesso, della regolazione della sequenza temporale del lavoro retribuito in modo da consentire, da un lato, alla persona di aggiustare il tempo di lavoro alle proprie esigenze nelle diverse fasi del ciclo di vita lavorativa e, dall'altro alle imprese, di ridurre i costi di riorganizzazione dei processi produttivi conseguenti alla implementazione di nuovi modi di occupazione. In altro modo, non si tratta tanto di procedere ad una riduzione dell'orario di lavoro, rilanciando lo slogan degli anni ottanta: “lavorare meno, lavorare tutti”. In realtà, oggi gli orari di fatto di lavoro si stanno allungando e, dall'altro, le stesse discussioni a livello internazionale sugli orari di lavoro definiti per legge o tramite la contrattazione collettiva si stanno arenando. Piuttosto, il nodo da sciogliere è l'articolazione dei tempi – e la suddivisione del tempo di lavoro tra lavoro retribuito a prezzi di mercato e lavoro diversamente retribuito. (M.A. Confalonieri, L. Canale, “Le politiche di conciliazione famiglia e lavoro”, in V. Fargion e E. Gualmini (a cura di), Tra l'incudine e il martello, Il Mulino, 2012).
Il problema si presenta in tutta la sua complessità nel caso della donna dal momento che, come è ben noto, i cicli di carriera delle donne sono asincronici e sfasati rispetto a quello degli uomini. L'organizzazione tayloristica del lavoro, che è stata dominante durante l'intero Novecento, prevede tre cicli distinti, in ciascuno dei quali vengono sviluppate abilità diverse da parte del soggetto lavoratore. La carriera inizia negli anni venti, quando al giovane lavoratore viene richiesto di imparare a fare e soprattutto di obbedire; accelera negli anni Trenta, quando al funzionario o al neo-dirigente si chiede di mettere alla prova le sue abilità relazionali e le sue capacità organizzative; consegue il picco negli anni Quaranta, quando ci si aspetta che il dirigente diventi, passo dopo passo, leader, per poi spiccare il volo verso il top management negli anni successivi. Ebbene, questo pattern lineare e ininterrotto della progressione di carriera, pensato per l'uomo bread winner, non si confa di certo alla situazione della donna perché è nel corso del secondo ciclo che essa può generare figli e dedicare speciali attenzioni alla famiglia. La conseguenza è che al loro rientro in azienda agli inizi del terzo ciclo, le donne trovano le posizioni apicali già occupate dagli uomini.
Non sono dunque i figli ad impedire l'avanzamento di carriera delle donne quanto piuttosto un'ottusa e arcaica organizzazione del lavoro che si ostina a non voler riconoscere la diversità dei modi di espressione dei cicli di carriera della donna rispetto a quelli dell'uomo. Accade così che in Italia, mentre la propensione della donna all'occupazione diminuisce dopo la nascita del primo figlio, quella degli uomini aumenta. Il tasso di attività maschile sale infatti dall'85,6% di chi non ha ancora figli al 97,7% di chi ha avuto un figlio, mentre il tasso d'occupazione balza dall'80,5% al 94,6%. Per le neo-mamme, invece il tasso attività scende dal 63% al 50% e quello di occupazione dal 57,2% al 48,4%. Non solo, ma le donne tendono a non rientrare nel mondo del lavoro: le donne che lavorano con figli di età maggiore di 15 anni sono nel nostro paese solamente il 56% (Isfol, Roma, 2009). E anche quando conservano l'impiego, le donne devono ridurre l'orario di lavoro e soprattutto il livello di responsabilità e di conseguenza la retribuzione effettiva.
Quanto sopra vale e farà comprendere il fenomeno di recente messo in luce dalla economista inglese Alison Wolf. Nel suo fortunato libro, (XX Factor, Londra, 2013), la Wolf evidenzia l'esistenza di un divario crescente tra donne privilegiate – quelle del fattore XX – e quelle meno fortunate, un divario che si aggiunge a quello, ben nota, tra ricchi e poveri. “Nella fascia più alta delle retribuzioni, nei paesi OCSE, uomini e donne sono pagati allo stesso modo e le donne accumulano ricchezza ad un ritmo superiore a quello degli uomini” (pag. 17). Quanto a dire che laddove non v'è discriminazione nel passaggio dal secondo al terzo ciclo, le donne non solamente riescono a tenere in armonia carriera e famiglia, ma sono in grado di usare il potere acquisito per modificare l'organizzazione del lavoro entro l'impresa. (Celebre, ma non unico, l'esempio di Sheryl Sandberg che diventata amministratore di Facebook, ha vinto la sua battaglia per far uscire tutti dal lavoro alle ore 17.30 per consentire ai genitori di giocare alla sera con i propri figli!).
Se si accetta il principio, come ritengo si debba accettare, che il lavoro di cura familiare non deve rimanere unica prerogativa femminile, occorre dire che la storica intesa del marzo 2011 tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro” non ha scongiurato affatto il rischio della produzione di effetti perversi. Per spiegarmi, si prenda il caso della L. 196/1997, della L. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003. Si tratta di provvedimenti legislativi che, introducendo i contratti di lavoro atipici, hanno diffuso la pratica del lavoro flessibile. Il risultato è stato che queste nuove forme di lavoro hanno avuto ricadute negative sulla famiglia – sia sulla vita di coppia sia sui figli. La ragione è presto detta. Poiché il contratto atipico lascia al lavoratore la facoltà di organizzare modi e tempi con cui realizzare l'obiettivo pattuito, si ha che, per una pluralità di ragioni, nella vita del lavoratore si alternano periodi di iperlavoro con periodi di scarsa attività, con le ricadute negative sulla vita di famiglia che è agevole immaginare. Quando poi anche la moglie avesse il medesimo tipo di contratto, la pratica impossibilità di sincronizzazione dei tempi liberi di moglie e marito porta a situazioni veramente grottesche entro la famiglia. Non è certo di questa flessibilità – solo finalizzata alle esigenze di produttività dell'impresa – che una autentica politica della famiglia ha bisogno. Si tenga presente, infatti, che il lavoro flessibile, se non accompagnato da robuste pratiche di flexsecurity, tradisce le aspettative della armonizzazione tra famiglia e lavoro. Esso amplifica le diseguaglianze sia di genere sia di territorio, fra chi ha famiglia e chi non ce l'ha.
Prima di lasciare l'argomento, conviene che precisi che le politiche di armonizzazione sono vantaggiose anche per l'impresa che si pone alla ricerca di modelli organizzativi family-friendly. È bensì vero, infatti, che nel breve periodo l'azienda dovrà sostenere costi specifici per applicare misure di armonizzazione. Ma i benefici diretti e indiretti sono di gran lunga superiori. Si tratta della riduzione dell'assenteismo, della diminuzione del turn-over; degli aumenti di produttività associati alla riduzione del free-riding e dello shirking; e soprattutto dell'aumento del capitale di connessione (connective capital) che oggi è il fattore decisivo della capacità di innovazione dell'impresa. Il punto, allora, non è se l'impresa familiarmente responsabile è in grado di competere o meno sul mercato. Piuttosto, la questione vera è come accelerare il cambiamento della cultura organizzativa aziendale, ancora troppo legata a quell'approccio taylorista che, mentre prescrive la separazione netta tra lavoro e famiglia – come se il lavoratore entrando in azienda potesse scordarsi della sua identità di coniuge e di genitore –, è al tempo stesso incapace di affrontare le sfide del diversity management per valorizzare la diversità dei talenti, soprattutto di quelli femminili.
3.4. Giungo così alla terza classe di provvedimenti; quelli che riguardano il nostro assetto istituzionale e amministrativo. L'idea che sta alla base di un assetto amico della famiglia è che quest'ultima non può essere pensata unicamente come “soggetto con bisogni”. Invero, il paradigma della mancanza, della privazione, rischia di bloccare le famiglie in una posizione di oggetto di cura, di presa in carico. La logica intrinseca a tale paradigma frena – al di là delle intenzioni – la famiglia, perché le impedisce di far fiorire le sue potenzialità nascoste e di trasformare il suo bisogno in una creatività singolare. Sappiamo bene, al contrario, che il grande valore della famiglia italiana è quello di essere stata un soggetto di reddito, un soggetto capace di intraprendere, di investire, di risparmiare e così facendo di patrimonializzarsi. Ecco perché la famiglia italiana deve chiedere rispetto per la sua specifica identità, e tornare ad essere soggetto, come lo fu fino agli anni settanta del secolo scorso, se vuole scongiurare il rischio di diventare oggetto della politica – sia pure di una politica compassionalmente generosa.
Alla luce di ciò, un primo suggerimento è quello di aumentare la dotazione, alquanto modesta, del Fondo per le Politiche Familiari, introdotto dalla L. 296/2006, mediante l'approntamento di piattaforme, specificamente dedicate, di crowdfunding e l'avvio dei nuovi strumenti di finanza etica del tipo obbligazioni sociali, social impact bonds, e altri del genere. Se si considera che le famiglie italiane spendono ogni anno dai 20 ai 22 miliardi di euro per le cure odontoiatriche, per gli studi dei figli, per assistere gli anziani non autosufficienti, per la cura dei bambini e così via, si capisce come la messa in campo di nuovi strumenti finanziari potrebbe favorire il conseguimento di un duplice obiettivo. Per un verso, razionalizzare una spesa che, essendo effettuata su base atomistica, cioè non organizzata, non è capace di sfruttare le economie di scala e soprattutto non è capace di inviare messaggi credibili ai soggetti di offerta. (Si pensi ai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) – erano 50 nel 2000; oggi sono oltre 900 – sostenuti prevalentemente dalle associazioni famigliari. Il loro obiettivo non è tanto quello di ottenere un abbassamento dei prezzi; piuttosto è quello di porre in pratica la strategia del “voto col portafoglio”). Per l'altro verso, incentivare l'aggregazione della domanda sociale di beni e servizi mediante una piena valorizzazione del ruolo dell'associazionismo familiare, il quale affiancherebbe alle tradizionali, e sempre necessarie, funzioni di advocacy e di counseling, le funzioni tipiche di un soggetto in grado di orientare le famiglie portatrici di bisogno verso il sistema delle delle risposte – risolvendo così, almeno in parte, il crescente disallineamento tra bisogni e risposte – unendo le loro capacità cognitive e relazionali.
Un secondo suggerimento è quello di quello di dare vita, nei diversi territori, al Distretto Famiglia sull'esempio di quanto già attuato dalla Provincia di Trento con L.P. 2 marzo 2011: “Sistema integrato per la promozione del benessere familiare e della natalità”, e successivamente replicato in altri contesti. L'idea al fondo del Distretto Famiglia è tanto semplice quanto efficace: consentire la costruzione di “Alleanze locali per le Famiglie”, così come la Germania è andata realizzando in tempi recenti. La cifra del Distretto è la governance di tipo societario, secondo cui tutti i soggetti realmente interessati al benessere delle famiglie, uniscono conoscenze, risorse economiche, beni relazionali, capacità imprenditoriali per la realizzazione di progetti concreti e non già per avanzare proposte o desideri vari. (Come sappiamo, in Italia è ancora difficile far comprendere le differenze tra proposte e progetti; il che spiega, fra l'altro, perché il nostro paese non riesce a utilizzare le ingenti risorse del Fondo Sociale Europeo – il quale finanzia solamente progetti!).
Il principio regolativo di tale modello di governance è la sussidiarietà circolare (da non confondersi con quella verticale e orizzontale), secondo il quale le tre sfere di cui si compone l'intera società – la sfera degli enti pubblici, quella delle imprese di tutti i tipi, quella della società civile organizzata (associazionismo, ONG, cooperative sociali, fondazioni) – devono definire tra loro, in condizioni di parità, le regole per giungere, dapprima, alla programmazione degli interventi e, poi, per assicurarne la gestione. Si badi che non basta la comunanza nella gestione dei progetti a definire la sussidiarietà circolare, questa deve estendersi anche alla fase della progettazione, la quale non può essere affidata esclusivamente all'ente pubblico, come erroneamente si continua a pensare, perché si continua a identificare lo spazio del pubblico con quello dell'ente pubblico – Stato o Regione o Comune che sia.
Un ultimo suggerimento, anch'esso fattibile, riguarda l'istituzione, su base nazionale nazionale, del Marchio Famiglia, allo scopo di dare ali e spessore alle varie espressioni del welfare aziendale di cui si va parlando da qualche tempo in Italia quando si discute di passare dal welfare state al welfare societario. Occorre essere espliciti e diretti su tale punto. Se realmente si vuole che il welfare aziendali diventi qualcosa di serio, un pilastro del nuovo modello di welfare che si va profilando e non già qualcosa che viene lasciato alla libera scelta di imprenditori illuminati e generosi – che, per fortuna di tutti, esistono nel nostro paese – allora è necessario istituire un sistema di rating che consenta la misurazione e la valutazione della qualità dei servizi resi alle famiglie e sulla cui base procedere all'assegnazione del Marchio a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che liberamente chiedono la certificazione di “organizzazione familiarmente responsabile”. Va da sé che dovrà prevedersi un sistema premiante a favore di chi ottiene il Marchio. Perché, come ci ha insegnato Giacinto Dragonetti (Delle virtù e dei premi, Carocci, Roma 2011; ed. orig. 1766), essendo la virtù più contagiosa del vizio – come insegnava Aristotele –, è indispensabile far conoscere a tutti le azioni virtuose che vengono compiute. (Sempre rimango stupito, e amareggiato, quando mi accade di ascoltare i discorsi di chi, con una gran dose d'ipocrisia, proclama che il bene fatto non deve essere portato a conoscenza del largo pubblico!).
Da ultimo, l'istituzione della Giornata Mondiale della Famiglia rappresenterebbe l'occasione più adeguata per procedere all'assegnazione del Marchio Famiglia, otre che portare alla ribalta tutta una serie di altre iniziative. Come si sa, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994 proclamò il 15 maggio di ogni anno il giorno dedicato alla celebrazione della Giornata Internazionale della Famiglia. Finora l'Italia non ha corrisposto a tale invito in modo formale: deve ora farlo, nell'occasione del XX anniversario di quella importante decisione. Chiaramente, l'organizzazione (e l'agenda) della giornata deve vedere il coinvolgimento diretto e preminente dell'associazionismo familiare e degli altri soggetti della società civile; non deve comportare oneri per lo Stato, né deve interrompere la normale attività scolastica, ma deve costituire un momento forte della vita culturale e spirituale del paese.
4. Anziché una conclusione
In due saggi di alcuni anni fa che hanno avuto grande eco nel dibattito pubblico in ambienti anglosassoni – l'uno di David Popenoe, l'altro di Judith Stacey – veniva difesa una tesi forte seguendo una strategia argomentativa del seguente tipo. Dapprima si cercava di documentare che in tutte le società moderne la famiglia è in declino in cinque sensi specifici: è meno orientata del passato verso obiettivi di natura collettiva; ha pressoché cessato di svolgere funzioni tradizionali come la procreazione, il controllo della sessualità, la socializzazione dei giovani; ha perso potere rispetto ad altre istituzioni come lo Stato, la scuola, la chiesa; è divenuta instabile; intrattiene legami sempre più labili con i singoli individui. Da qui si passava poi a concludere che la famiglia moderna (matrimonio stabile, marito che lavoro per il mercato, e moglie che lavora per la casa) va lasciando il posto ad un insieme di organizzazioni domestiche differenziate, spesso precarie, che connotano la famiglia post-moderna: madri single; famiglie allargate; coppie conviventi; coppie omosessuali. (Uno studioso americano ha rilevato la presenza negli USA di oggi di 54 tipi di famiglie!). La famiglia post-moderna sarebbe dunque adatta per assecondare le esigenze sia dell'economia post-moderna sia del post-femminismo. “La famiglia non esisterà per sempre – scrive la Stacey – e non dovremmo augurarci che ciò avvenga. Al contrario, credo che tutti coloro che si sentono democratici... dovrebbero cercare di accelerare il declino di questa istituzione. La famiglia allontana e svaluta una ricca gamma di possibili legami” (sic!). (J. Stacey, Brave New Families, New York, Basil Books, 1990).
Per fortuna, la realtà si è incaricata di svelare l'implausibilità teorica e l'infondatezza pratica di una tesi del genere. Chiaramente, i due Autori hanno scambiato un finale d'atto per la fine della rappresentazione e hanno applaudito con troppo anticipo. Non che le statistiche non evidenzino i segni preoccupanti della crisi odierna della famiglia, come abbiamo abbondantemente documentato; ma le statistiche di per sé nulla dicono a supporto della tesi sopra riferita. Sarebbe un non sequitur logico concludere che la famiglia è destinata a scomparire. In primo luogo, perché la famiglia è sempre stata in crisi. Essendo un ente vivente la famiglia si trasforma, evolve. Ed ogni trasformazione sempre si porta appresso la crisi – che, in greco, significa passaggio, transizione. Ma ciò non implica affatto né che sia finita, né che sia spacciata, come il brano sopra citato chiaramente indica. Alla fine del secolo scorso, era frequente vedere citata la metafora del “costume di Arlecchino” per veicolare l'idea che non esiste la famiglia: esistono le famiglie e ciascuno deve essere lasciato libero di scegliersi il tipo a lui/lei più confacente. Ma modelli plurimi di famiglie esistevano anche nel passato; né si può affermare che le famiglie monoparentali sono un'invenzione dei tempi presenti. Vero è, invece, che in questo inizio di nuovo millennio, parecchi sono i segnali di un rinnovato interesse alla questione della famiglia: basta non avere paraocchi ideologici per rendersene conto.
In quanto seminarium civitatis – Cicerone preferiva l'espressione seminarium rei publicae – la famiglia mai può dimenticare che la sua missione è anche quella di rendere lo Stato più civitas (e meno polis). E poiché è la civitas che genera la civilitas, si può comprendere perché, oggi più che mai, c'è disperato bisogno della famiglia. La quale però deve sforzarsi di più di coltivare quella che l'antropologo indiano Arijum Appadurai ha chiamato la capacità di aspirare (capability to aspire). È questa la capacità che chiama in causa la partecipazione delle persone alla costruzione delle rappresentazioni sociali e simboliche che danno forma al futuro, ai progetti di vita. Un celebre racconto di Chatwin ci svela come si può fare per coltivare questa capacità. Ecco. Un bianco schiavista riesce a convincere i suoi portatori neri ad accelerare il passo in cambio di denaro. Nonostante l'accettazione iniziale dell'offerta, i portatori si fermano molto vicini alla meta e non vogliono procedere oltre. Richiesti della spiegazione del loro irrazionale comportamento, rispondono: “per dare tempo alle nostre anime di raggiungerci”.
E' proprio così: di tanto in tanto abbiamo bisogno di sostare per consentire alla nostra anima di raggiungerci.
1Sulle politiche europee di conciliazione, si veda M. Naldini e C. Saraceno, Conciliare famiglia e lavoro, Bologna, Il Mulino, 2011.